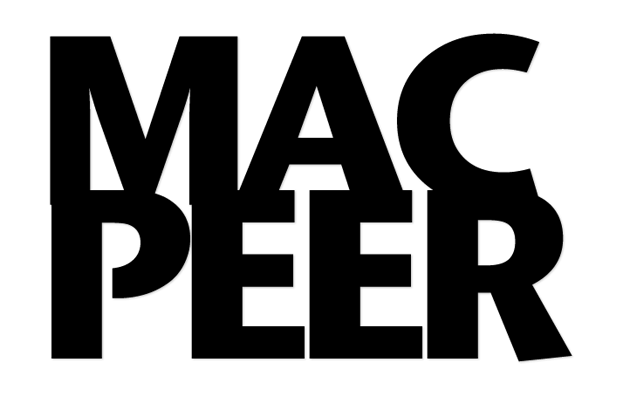Il corpo macchina dell’intelligenza artificiale.
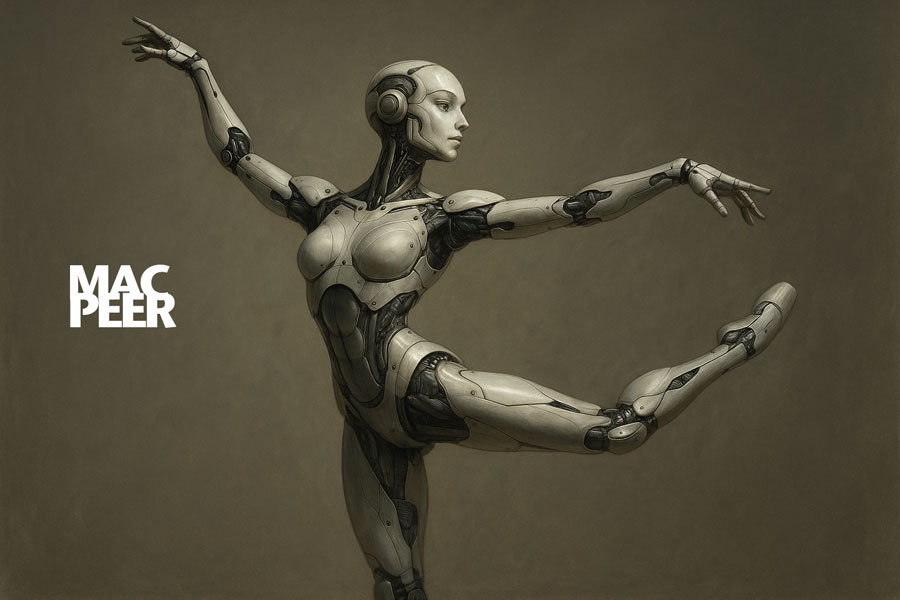
Siamo abituati a pensare all’intelligenza artificiale come a una mente eterea che vive nel cloud, in uno spazio sospeso tra i server di Google e gli algoritmi di OpenAI. Ma, come ricorda Simona Stano nell’articolo pubblicato su semiotica.org, l’IA ha — prima di tutto — un corpo. Un corpo macchina, fatto di ventole, chip, dissipatori e circuiti. E, aggiungiamo noi, di alluminio anodizzato, display Retina e chip Apple Silicon.
Perché sì, anche l’intelligenza artificiale — oggi più che mai — vive dentro i nostri Mac, nei nostri iPhone, così come nei nostri iPad. E questa incarnazione quotidiana della macchina intelligente racconta qualcosa di molto diverso dai supercomputer da laboratorio.
Dalla ballerina ai chip M
Nel suo articolo, Stano cita esperienze artistiche come Talker e Angel_F, in cui l’IA prende corpo: nella tuta sensoriale di una ballerina o nel volto proiettato di un “bambino digitale” che dialoga con i passanti. L’intelligenza, lì, non è più un algoritmo nascosto, ma un corpo visibile, un soggetto che si espone e interagisce.
Oggi, in modo meno poetico ma più concreto, lo stesso succede quando parliamo di Apple Intelligence: l’IA integrata in macOS, iOS e iPadOS non vive più nei datacenter lontani, ma nei chip M e A dei nostri dispositivi. È un corpo miniaturizzato, compatto, lucidato fino a sembrare invisibile — ma pur sempre un corpo.
Il Mac, in fondo, è diventato un piccolo “supercomputer” personale. Un Summit da scrivania, con un design infinitamente più elegante e una potenza che, in proporzione, non ha nulla da invidiare ai giganti dei laboratori. La differenza? Questo corpo macchina è personale: lo tocchiamo, lo portiamo nello zaino, lo apriamo con un gesto del polso.
L’AI che non pensa, ma sente (un po’)
Come scrive Stano, anche nei sistemi di embodied AI manca ancora qualcosa: “la capacità di collegare sensi e senso”. È un’osservazione semiotica sottile ma fondamentale. La macchina può riconoscere un volto, una voce, un pattern, ma non sa davvero cosa significhi quel volto o quella voce per noi.
Eppure, con Apple, stiamo vedendo un passo avanti interessante: non l’IA che pensa, ma quella che ascolta e anticipa. L’AI di Siri riscritta da zero, quella che suggerisce risposte, genera testi o sintetizza immagini, non pretende di essere umana, ma lavora per comprendere il contesto. Si direbbe quasi che Apple punti a una semiotica applicata del contesto, più che a una pura imitazione dell’intelletto.
Il Mac e l’iPhone diventano così dispositivi trans-corporei: protesi cognitive che estendono la nostra percezione. Non c’è la tuta di lattice di Talker, ma ci sono sensori, fotocamere, microfoni, accelerometri — tutto ciò che rende la macchina sensibile al mondo. Non “umana”, certo, ma capace di un tipo di percezione tecnica che traduce i nostri gesti e le nostre parole in dati.
Dal corpo-macchina al corpo-utente
C’è poi un aspetto che a Cupertino conoscono benissimo: l’intelligenza artificiale, per quanto sofisticata, prende forma solo nel rapporto con il corpo umano. È il tocco sul trackpad, l’inclinazione dello schermo, il modo in cui guardiamo Face ID.
Apple da anni lavora per rendere questo confine impercettibile. Il “corpo macchina” e il corpo dell’utente non sono più due entità distinte: la fotocamera TrueDepth legge i nostri movimenti, l’Apple Watch misura il battito cardiaco, i nuovi AirPods monitorano persino la postura. La macchina non si limita a calcolare: ci osserva per capire come siamo.
È un’alleanza quotidiana, discreta e silenziosa. Mentre apriamo Safari o scriviamo in Pages, miliardi di operazioni neurali accadono dietro le quinte, come se il Mac respirasse con noi. Forse è questo il nuovo corpo dell’intelligenza artificiale: una rete di dispositivi che si muove con il nostro stesso ritmo vitale.
Una semiotica del silicio
Simona Stano scrive che la macchina, anche quando interagisce con l’ambiente, “manca del substrato semiotico che permette la costruzione soggettiva e intersoggettiva del significato”. Ed è vero. Ma forse l’evoluzione dei dispositivi Apple ci mostra una via diversa: non un’intelligenza che capisce, ma una macchina che coopera.
Il corpo macchina dell’IA non è più un oggetto isolato in un laboratorio, ma un ecosistema distribuito: tra Mac, iPhone e iPad si costruisce una semiosi fluida, fatta di gesture, voce, interfacce tattili e riconoscimenti contestuali. È un linguaggio ibrido, a metà tra codice (informatico) e comportamento: la comunicazione uomo-macchina non passa più solo attraverso simboli o interfacce grafiche (le icone, le parole, i comandi), ma attraverso forme di interazione semiotiche, in cui il gesto o l’abitudine diventano parte del linguaggio stesso.
È un linguaggio nuovo, fluido, dove la macchina interpreta i nostri comportamenti come segni — e costruisce con essi una grammatica di interazione.
E se la semiotica ci insegna che il significato nasce nell’interazione, allora forse è proprio qui — tra l’alluminio del MacBook e la pelle del polso che indossa un Apple Watch — che l’intelligenza artificiale trova il suo corpo più autentico.