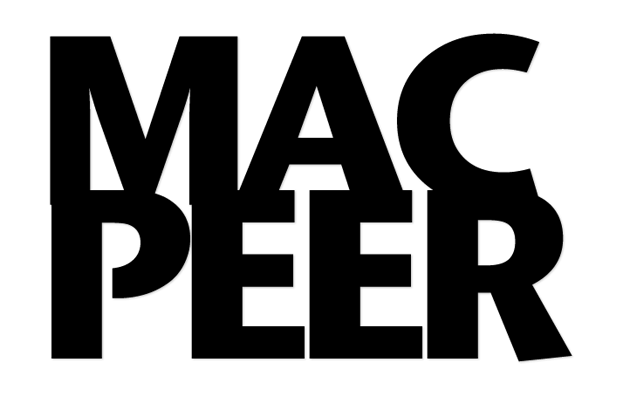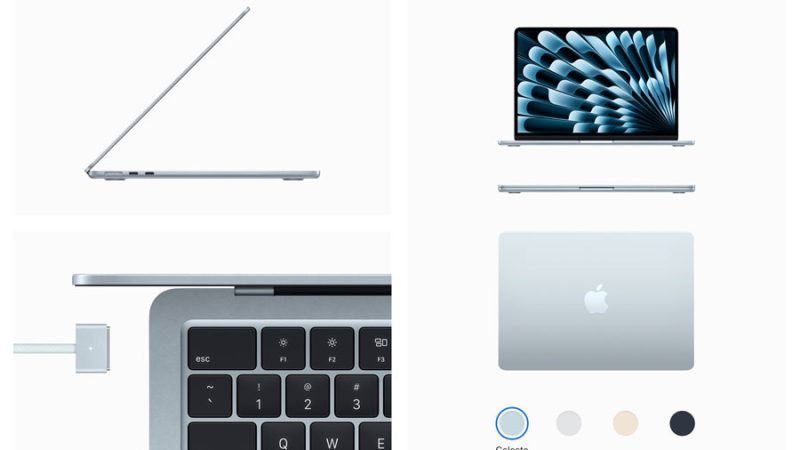Il mito dell’intenzionalità originaria
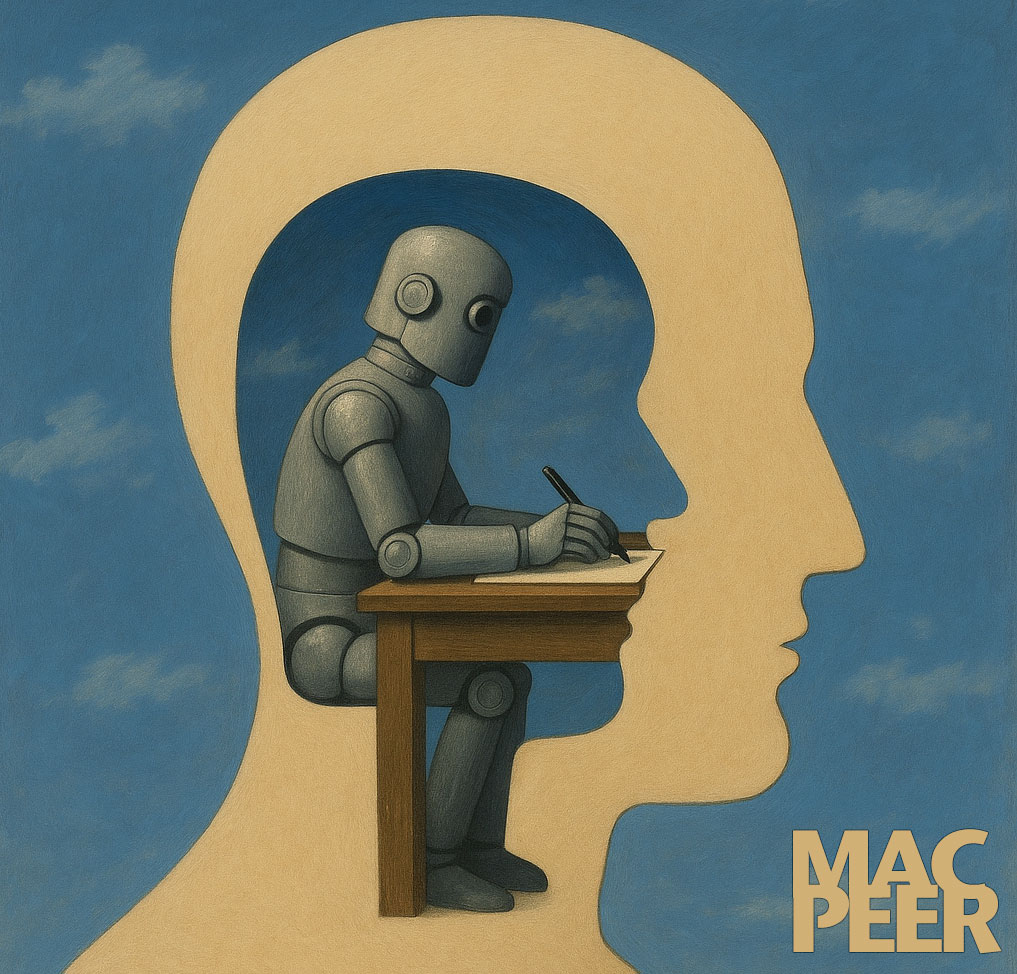
Nel saggio “Il mito dell’intenzionalità originaria”, Daniel C. Dennett muove una critica articolata alla tesi di John Searle, secondo cui solo un cervello biologico umano sarebbe capace di produrre stati mentali dotati di intenzionalità originaria, ossia intrinseca e non derivata. Questo tipo di intenzionalità, secondo Searle, non sarebbe riproducibile da nessuna macchina, per quanto sofisticata, proprio perché legata alla specifica natura biologica del cervello.
Dennett respinge questa visione, che giudica “dogmatismo del senso comune”. Lungi dal contestare la validità di una Intelligenza Artificiale “debole” (strumento utile allo studio della mente), Searle attacca invece l’Intelligenza Artificiale “forte”, quella che pretende di replicare letteralmente la mente umana. Ma per Dennett, le argomentazioni di Searle — a partire dall’esperimento mentale della Stanza Cinese — si fondano su premesse ambigue o errate: «gli errori logici contenuti nell’esempio della Stanza Cinese sono messi in luce, in modo a mio parere definitivo, in Hofstadter e Dennett, 1981».
Il cuore della disputa ruota attorno a due proposizioni. Searle sostiene (proposizione S) che «solo un cervello umano organico può avere i poteri causali richiesti per produrre l’intenzionalità». Dennett propone invece la più sobria proposizione D: «solo un cervello umano organico può produrre l’attività mentale pronta e intelligente che vediamo negli esseri umani normali». Una distinzione che consente di aggirare il problema metafisico dell’intenzionalità “vera”, spostando l’attenzione sulle capacità effettive di un sistema di interagire in tempo reale con l’ambiente.
Dennett non nega che l’intelligenza dipenda da una complessità strutturale difficilmente replicabile: il parallelismo massiccio del cervello, la sua velocità di elaborazione, forse persino caratteristiche molecolari dei neuroni. Tuttavia, osserva che queste proprietà potrebbero un giorno essere riprodotte in modo funzionale, anche se non biologico. E se così fosse, avremmo dispositivi con comportamento indistinguibile da quello umano. Perché, si chiede Dennett, dovremmo negare che “abbiano una mente”?
Al centro del suo ragionamento sta la nozione di “punto di vista intenzionale”, un metodo interpretativo: si considerano certi sistemi come se avessero credenze, desideri, scopi — non perché ne siano dotati “intrinsecamente”, ma perché questa descrizione predittiva funziona. Dennett osserva che anche gli enzimi o i geni sono spesso descritti con linguaggio intenzionale (“impediscono”, “scelgono”, “desiderano”), pur essendo entità chimiche prive di coscienza. Questa “intenzionalità del come se”, scrive, è uno strumento esplicativo potente — e lo stesso vale per i sistemi artificiali.
Ma allora, da dove viene la nostra intenzionalità? La risposta di Dennett è provocatoria: «Siamo artefatti, costruiti nel corso delle ere biologiche per garantire la sopravvivenza dei geni». Proprio come un robot progettato per custodire un essere umano ibernato per secoli, anche noi siamo meccanismi di sopravvivenza automatizzati — progettati dalla selezione naturale, non da un dio. Madre Natura, scrive, è la vera artefice: opera per tentativi, ma con una sorta di lungimiranza evolutiva che produce esseri coscienti.
La conclusione è radicale: l’intenzionalità originaria non esiste. Ciò che chiamiamo intenzionalità è sempre derivata, anche nel caso dell’uomo. Derivata da processi evolutivi ciechi, ma efficienti. Come la lista della spesa annotata nella mente non differisce, per natura semantica, da quella scritta su carta, così anche la nostra coscienza non sarebbe altro che un prodotto sofisticato, ma non “originario”, del processo evolutivo.
Dennett risponde infine all’obiezione più istintiva di Searle: ma noi sappiamo di avere vera intenzionalità. E replica che questa “convinzione interiore” non è argomento filosoficamente sufficiente, ma solo il sintomo di un’adesione acritica a un “dogma confuso”.
Riferimento bibliografico: D.C. Dennett, Il mito dell’intenzionalità originaria.