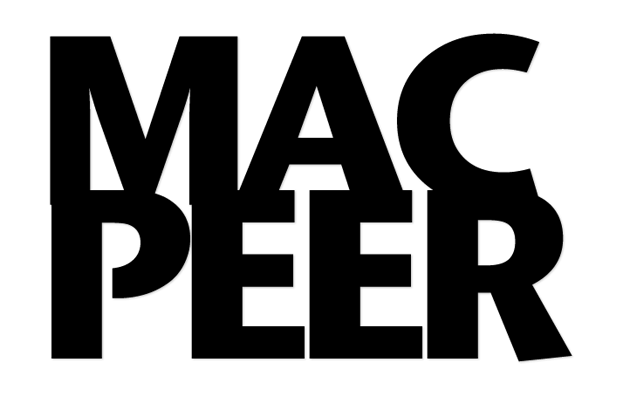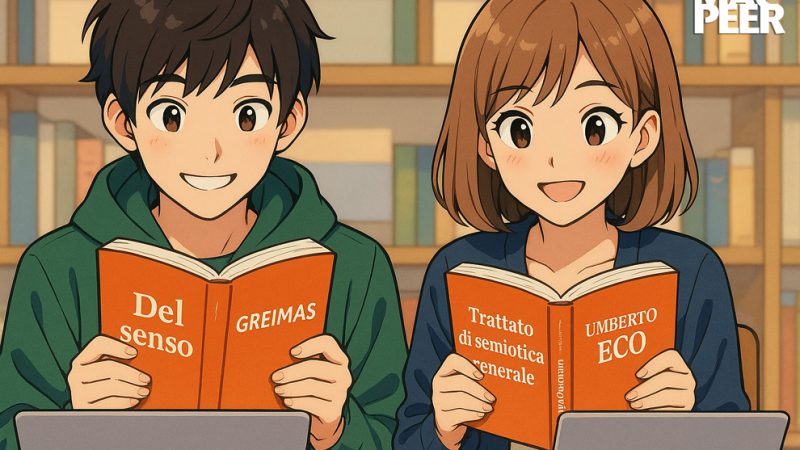Musica in streaming 1/5 – Dalle origini al dominio on-demand

Da quando, in una camera di college a Boston, Shawn Fanning mise insieme un programma chiamato Napster immaginando un futuro in cui ogni appassionato avrebbe potuto condividere istantaneamente la propria musica, il modo di intendere l’ascolto è cambiato per sempre. Napster comparve nel 1999 come un lampo di libertà digitale: con un’interfaccia tutt’altro che sofisticata, consentiva di cercare e scaricare brani in formato MP3 direttamente dai computer degli altri utenti, abbattendo ogni confine geografico o economico. In pochi mesi, decine di milioni di persone aderirono a quel sogno di accesso universale, fino a quando, due anni più tardi, le major – allarmate dai bilanci sempre più risicati – non misero fine all’esperimento con una serie di battaglie legali che portarono alla chiusura del servizio nel 2001.
Ma la scintilla era ormai divampata: da quel momento, l’industria musicale capì che il digitale non era solo un’alternativa al CD, ma una rivoluzione destinata a consumare ogni margine di profitto se non si fosse rapidamente adeguata. La risposta più immediata venne da Apple, che nel 2003 inaugurò l’iTunes Store, offrendo per 0,99$ a brano un catalogo legale in download. Per molti appassionati fu la prima occasione di “comprare” musica in formato digitale, con la comodità di ritrovarsela salvata sul computer e sincronizzata con il neonato iPod. In pochi anni, iTunes arrivò a vendere cinque miliardi di canzoni, trasformando il singolo download in un’abitudine diffusa – ma ancora impegnativa sul piano logistico: ogni traccia doveva essere fisicamente trasferita e archiviata, consumando spazio e richiedendo un minimo di organizzazione personale.
Il vero spartiacque arrivò però con lo streaming on-demand. Nel 2006, un gruppo di imprenditori svedesi fondò Spotify, e due anni più tardi lanciò un servizio che cambiava le regole: invece di scaricare file, si poteva ascoltare istantaneamente ogni brano del catalogo in cloud, previa connessione a internet. L’interfaccia, semplice e familiare, permetteva di creare playlist, esplorare generi o lasciarsi guidare da suggerimenti calibrati mediante algoritmi di machine learning. Il modello freemium – gratis con spot pubblicitari oppure a pagamento per un’esperienza senza interruzioni – si rivelò vincente. In pochi anni Spotify conquistò l’Europa, sbarcò negli Stati Uniti e, ad oggi, conta 515 milioni di utenti attivi ogni mese, di cui 236 milioni paganti.
La possibilità di accedere a un archivio quasi infinito, senza l’onere di possedere file o materiali fisici, riflette un cambio di paradigma radicale. L’ascolto diventava fluido come l’acqua di un rubinetto: non più un bene da acquistare e conservare, ma un servizio da consumare, sospendibile con un clic. Questo shift non si limitò a una questione tecnologica: investì l’intero tessuto dell’industria musicale. Già nel 2015 i ricavi dello streaming superarono quelli del download e del supporto fisico, segnando il passaggio definitivo a un’economia basata sugli abbonamenti e sulla pubblicità. Oggi, circa il 70 % degli incassi globali dalla musica registrata è generato dallo streaming, con i soli abbonamenti premium che rappresentano oltre la metà del fatturato complessivo e un giro d’affari superiore ai 15 miliardi di dollari all’anno.
Non furono solo Spotify e l’Europa a cavalcare l’onda: Apple adattò la propria offerta lanciando Apple Music nel 2015, puntando sull’integrazione perfetta nell’ecosistema iOS e su un catalogo in alta definizione senza costi aggiuntivi. Amazon, forte della base Prime e dei diffusissimi smart speaker Echo, potenziò Amazon Music Unlimited. YouTube trasformò la propria sezione musicale in YouTube Music, fondendo video ufficiali, live e lyric video in un’unica esperienza. Ogni piattaforma cercò di ritagliarsi un proprio spazio: Apple scommise sulle playlist curate editorialmente, Amazon sull’accesso integrato a Prime, YouTube sulla forza del video e Spotify sulle playlist generate dagli algoritmi e sul format virale dello “Spotify Wrapped” annuale.
Questo fermento diede nuovo slancio a un’industria uscita in crisi dalla pirateria e dal calo delle vendite fisiche. Case discografiche e artisti dovettero ripensare le strategie: l’uscita di un singolo ebbe un peso ancora maggiore rispetto al lancio tradizionale di un album, e l’attenzione si spostò sulla collocazione nelle playlist piuttosto che sulle rotazioni radiofoniche o sui negozi di dischi. La musica, da prodotto tangibile venduto a scaffale, divenne un flusso continuo di dati, tracciato in tempo reale, con ogni stream che alimenta statistiche dettagliate sul gradimento del pubblico e orienta scelte di marketing, tournée e investimenti futuri.
Oggi, mentre milioni di canzoni “nuove di zecca” vengono caricate ogni giorno sulle piattaforme (si stima oltre 120 000 al giorno), il privilegio di emergere spetta sempre più a chi sa destreggiarsi fra algoritmi e social media. Ma quella prima scintilla, esplosa nella cameretta di Shawn Fanning, resta la chiave di volta: da Napster a Spotify, passando per iTunes, ogni passo di questa storia ci ricorda che la musica vive – e prospera – dove l’accesso diventa libertà, e la libertà si misura nella capacità di toccare con un istante un pezzo del mondo sonoro che ci circonda.
Nel prossimo appuntamento ci immergeremo nei numeri odierni dello streaming globale, confrontando gli attori principali in termini di quota di mercato, strategie e rapporto con gli artisti, per capire come si contendono l’orecchio di centinaia di milioni di ascoltatori.